MARCO RIZZI
È difficile sottovalutare l’importanza per la teologia contemporanea di Jürgen Moltmann, morto lunedì 5 giugno all’età di 98 anni a Tubinga, dove era stato docente.
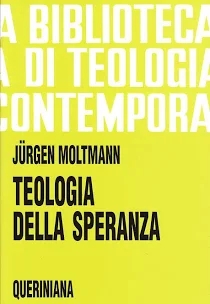
Proveniente da una famiglia borghese di Amburgo, per cui il cristianesimo riformato implicava un fattore di identità culturale piuttosto che la dimensione di fede, Moltmann amava ripetere che il suo incontro con Cristo era nato dalla drammatica esperienza della guerra, vissuta come giovanissima recluta e poi in campo di prigionia, dove la lunga permanenza fu l’occasione per riflettere a fondo su quanto accaduto e di maturare la scelta degli studi di teologia. Laureatosi a Göttingen e avviatosi alla carriera accademica dopo un quinquennio di attività pastorale a Brema, Moltmann raggiunse la notorietà nel 1964 con Teologia della speranza (tradotta in italiano dall’editrice Queriniana nel 1970), che ha segnato una nuova fase nella teologia protestante dopo la lunga egemonia di Karl Barth, il più influente teologo del Novecento.
Sin dal titolo, il libro di Moltmann si pone in dialogo con Il principio speranza del filosofo marxista Ernst Bloch, che mostra come l’agire umano sia indirizzato dalla speranza che spinge a ipotizzare e costruire il futuro, dagli aspetti più minuti della vita quotidiana alle grandi utopie politiche e ai sogni di trasformazioni rivoluzionarie: per Bloch, il motore della storia non è costituito dalla dialettica hegeliana, bensì dalla speranza, priva però di un fondamento e di un fine specifico che non sia il suo stesso darsi. Moltmann rivendica invece la specificità cristiana della speranza, necessariamente in relazione con la fede e con il suo fine ultimo, l’attesa del Regno: la speranza è «la compagna inseparabile» della fede, perché quest’ultima, senza la prima, non avrebbe ragione di essere — la fede cristiana è fede nel Cristo risorto — e, a sua volta, la speranza senza fede si ridurrebbe a mera utopia, priva di contenuto teologico.
In questo senso, l’esperienza e il ricordo della croce di Cristo risultano decisivi: in Il Dio crocifisso del 1972 (anch’esso tradotto da Queriniana) Moltmann chiarisce come la resurrezione di Gesù anticipi il compimento della storia e il futuro del Regno di Dio, dando senso all’intera esperienza umana: proprio perché inscindibilmente legata alla croce, la resurrezione di Cristo è speranza per chi appare senza speranza, è speranza per tutte le croci che l’umanità, collettivamente e individualmente, deve affrontare.
Non è quindi un caso che, dopo molti altri libri e decisivi interventi su temi quali l’ecumenismo, la creazione e l’ambiente, la teologia dopo Auschwitz, tra le ultime pubblicazioni di Moltmann sia apparso un volumetto, Risorto nella vita eterna (2020, tradotto sempre da Queriniana), nato dal dolore per la scomparsa della moglie, Elisabeth Wendel anch’essa teologa: «Mi sono occupato spesso a livello teologico del significato della resurrezione di Cristo per la nostra vita qui e per la nostra speranza nella vita eterna là (…). Ma da quando è morta mia moglie Elisabeth, la mia prospettiva è cambiata: il tema è diventato per me anche un problema personale. Perciò ho dovuto ancora una volta riconsiderarlo teologicamente». Ma, diversamente da una lunga tradizione di scritti spirituali, non ne è nata un’ars moriendi, una preparazione alla morte, bensì un’ars resurgendi, una preparazione alla pienezza della vita in cui tutte le cose e le persone che ciascuno ama avranno ancora futuro.
in “Corriere della Sera” del 6 giugno 2024