MARCO FERRANTE
Il fattore umano
Secondo un recente rapporto di Goldman Sachs, l’intelligenza artificiale potrebbe sostituire 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno nei prossimi dieci anni, e secondo il World Economic Forum poco meno di un terzo di questo avvicendamento potrebbe avvenire già nei prossimi due anni. I settori più toccati saranno quelli delle professioni intellettuali che forniscono servizi economici.
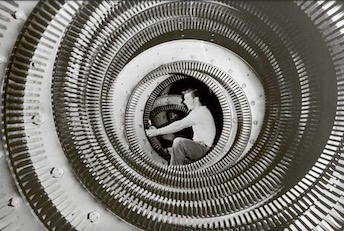
Tutte le analisi concordano su due punti. Il primo, in una certa quota l’intelligenza artificiale affiancherà la forza lavoro già impiegata. Il secondo, nasceranno nuove professioni perché le applicazioni dell’IA andranno sviluppate, perfezionate, rese compatibili con le esigenze di verità e di sicurezza che le democrazie esigono. Ma è impossibile prevedere l’impatto con una approssimazione attendibile. Nell’articolo a p. 14 si cita l’emblematico caso dell’introduzione dei bancomat negli Stati Uniti alla fine degli anni Settanta, che sostituì il lavoro dei cassieri ma non ne compromise i posti di lavoro. L’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, sul sistema economico e sul cuore dei processi decisionali sta scalando l’ordine di classifica dell’agenda globale.
Accanto alla questione occupazionale, ci sono altri due aspetti primari nella discussione. Uno riguarda il vero e il falso. È l’aspetto più dibattuto. Fino a oggi è stato generalmente possibile distinguere una immagine fake da una reale. La famosa immagine di papa Francesco con il piumino bianco è un buon esempio, perfetta e realistica da un punto di vista tecnico, ma inattendibile da un punto di vista razionale: per una persona informata non è politicamente e culturalmente credibile che il papa avesse scelto di indossare quel piumino.
Nelle scorse settimane i componenti superstiti dei Beatles hanno pubblicato una canzone, utilizzando vecchie tracce di un brano scartato, vivificate dalla tecnologia, e mescolando in un video le immagini di oggi e quelle di ieri. Nessun dubbio sulla natura del collage. Ma le cose cambiano velocissime, la tecnologia avanza e produce effetti molto realistici. Sui reel di Facebook e di Instagram spuntano interviste plausibili a nuovi divi o a personalità pubbliche realizzate grazie alle elaborazioni video prodotte dall’IA. Se non fossero accompagnate da avvertenze, sarebbe difficile accorgersi del falso: la speciale sgranatura delle immagini rende già quasi nulla la differenza tra l’audio e il movimento labiale. Il tutto a costi molto limitati.
Google ha appena lanciato un programma che permetterà di comporre brevi canzoni nello stile di artisti che hanno dato il loro assenso all’iniziativa. Per quanto possa apparire complesso o incomprensibile il senso di alcune di queste trovate – non tutte le nuove idee sono necessariamente ragionevoli o utili – è sempre più evidente che sono meccanismi che andranno regolati. Dipenderà dalla governance delle piattaforme di distribuzione e dalla relazione con gli operatori (lo scontro in seno a OpenAI è una spia delle tensioni in atto), dai controlli (qualcosa di paragonabile al funzionamento della blockchain, cioè l’evoluzione migliorativa di un registro di certificazione che traccia il processo di produzione) e infine dalla volontà di adottare eventuali sistemi sanzionatori integrati e condivisi dalle piattaforme e da organismi sovranazionali.
L’altro aspetto riguarda come sempre il ruolo dell’essere umano. L’evoluzione delle macchine dipende dall’uomo. Anche se fosse teoricamente possibile un futuro di macchine autodeterminate, sarebbe l’uomo a innescarlo e sempre l’uomo avrebbe gli strumenti per interromperlo. È una frontiera rischiosa, ma non è la prima volta. Viviamo da ottant’anni su una frontiera rischiosa. Le decisioni che avranno conseguenze sul mondo del lavoro le prenderanno i portatori di interessi e le autorità politiche.
C’è chi crede al rischio concreto di nuovi sbilanciamenti sociali e di un aumento delle diseguaglianze. Non sempre va così. L’introduzione della catena di montaggio portò un aumento delle retribuzioni, perché solo così fu possibile vendere automobili popolari anche agli operai che le producevano. Dovremmo prendere decisioni altrettanto difficili sulla sicurezza. Il 7 ottobre scorso, quello che viene considerato il paese più tec nologico del mondo, Israele, è stato costretto a fronteggiare una minaccia antica e basica. La minaccia non era stata sufficientemente percepita dagli uomini, nonostante l’aiuto della macchina tecnologica.
A questo destino – essere presente – l’uomo non può sfuggire. Come è successo a Londra: una bambina tenuta in vita da una macchina. Per quanto tempo e perché quella macchina deve essere accesa e funzionare dovremo sempre essere noi a deciderlo. Tanto maggiore è il progresso tecnologico e la potenza dei nostri congegni e delle nostre invenzioni, tanto maggiore sarà la nostra responsabilità. Per Graham Greene tutto il complesso di cose che ci porta a dare una direzione alla realtà si definisce fattore umano. Così intitolò uno dei suoi romanzi più belli e cupi. Come per altre sue opere, non ne fu mai troppo soddisfatto. Ma a giustificarne il senso ai suoi stessi occhi scrisse una piccola frase sentimentale e universale: «a salvare il romanzo rimaneva solo il fattore umano del titolo».
In Civiltà delle macchine, https://www.fondazioneleonardo.com/sites/default/files/downloads/2024-03/_Civilta%20delle%20Macchine%20n4-23%20x%20web%20%281%29.pdf