DERRIK DE KERCKHOVE, intervistato da EMILIANO MARRONE
“Già un decennio fa, quando si scoprì il valore dei Big Data, si sarebbe dovuto intuire che questa enorme sfera di informazioni aspettava solo le domande giuste. Oggi, grazie a ChatGPT, si parla di ‘ingegneria della domanda’. Si tratta di un’abilità che dovrebbe diventare una priorità in qualsiasi contesto educativo. In genere, in tutto il mondo, gli studenti non vengono educati a pensare ma solo a ricordare, cosa perfettamente inutile quando si vive in un ambiente di informazione costante”. Studio, comprensione, approfondimento: con la tecnologia che – giustamente – incalza, occorrono piloti che sappiano guidare sapendo di avere a fianco un copilota intelligente, molto abile e veloce. Dunque, si tratta di una questione di pensiero prima che di azione.
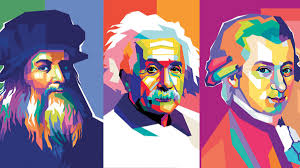
Il professore ha accettato un dialogo ad ampio spettro per inquadrare la vicenda dell’Intelligenza Artificiale nella prospettiva di un orizzonte più ampio che riguarda il rapporto fra la conoscenza umana e la sfida che portano le tecnologie digitali.
Anzitutto, abbiamo pensato a una domanda un po’ didattica: può aiutarci a creare una mappatura tra gli strumenti digitali? Una cosa è il metaverso, altra è ChatGPT, altra ancora i social media. Oltre agli strumenti di comunicazione e formazione di contenuti, poi, ci sono innumerevoli applicazioni che aiutano le persone in campo medico, lavorativo ecc. Quali distinzioni userebbe per identificare gli strumenti digitali?
Cercherei di distinguere quelli che, come la GenAI, entrano in una grande varietà di applicazioni – testo, video, immagine, programmazione ecc. – da quelli che, pur essendo anch’essi in grado di utilizzare la GenAI, sono più simili ad ambienti “monoscopi”, come il metaverso e tutte le sue varianti. Poi ci sono gli stessi strumenti monoscopi all’interno di quelli generici, come la miriade di plugin dell’ambiente GPT-4.
Ogni piattaforma di social media merita una propria categoria all’interno dell’ombrello più generale. Per quanto male, X (ex-Twitter) fa cose molto diverse da Meta (ex-Facebook) o da Instagram, Snapchat, TikTok, Reddit ecc.
Un’altra ricca categoria è quella degli assistenti digitali come Siri, Bixby, Alexa e così via. Questi non solo fanno riferimento a diverse piattaforme di livello superiore (Apple, Microsoft, Amazon), ma forniscono anche il loro servizio in modo diverso. Poi ci sono i motori di ricerca come Google, in cui si potrebbe voler includere Bard ma non si dovrebbe. Ciò perché Bard è più simile a un motore di pensiero, anche se Google è in grado di fondere entrambi gli strumenti.
Poi ci sono i distributori di musica: Spotify, Shazam, il servizio di Apple eccetera. Vi lascio immaginare gli altri, ma il mio criterio di classificazione sarebbe innanzitutto lo scopo dell’applicazione, e poi ciò che la differenzia da altre della stessa categoria. Quando parlo di “intelligenza connessa”, preciso che significa due cose diverse: la prima, un’associazione di persone che lavorano a un progetto comune; la seconda, le differenze tra le configurazioni di piattaforme e applicazioni. La categoria superiore è quella dei sistemi operativi (OS), perché comandano tutte le applicazioni. È una cosa molto diversa lavorare con Microsoft, Apple, Ubuntu o Linux, e può durare settimane la migrazione corretta da un sistema all’altro.
Come si rapportano la velocità di sviluppo/cambiamento della tecnologia digitale e la velocità “umana” di comprensione e apprendimento?
Male. Noi, le persone, stiamo correndo da una tecnologia di riferimento a un’altra. Non abbiamo ancora assorbito i benefici sociali e i drastici effetti politici dei social media, che dobbiamo confrontarci con le conseguenze del cambiamento quotidiano delle prestazioni e delle applicazioni dell’IA generativa. La curva di apprendimento è molto più lenta e non è più solo individuale ma è generazionale.
Tempo fa, avevo previsto che solo la successione delle generazioni più giovani sarebbe stata in grado di gestire gli indispensabili cambiamenti portati dalle tecnologie digitali, semplicemente perché dotata di un sistema nervoso più fresco. Ma non ne sono più così sicuro. Sono rimasto molto sorpreso nell’osservare un generale disinteresse nella mia classe (di 37 studenti) al Politecnico di Milano per la chat e altre varianti della GPT. Non gliene importava alcunché. Forse lo danno per scontato, come fanno per tutti gli altri straordinari poteri che la trasformazione digitale offre loro ogni giorno. Sembra che non si rendano conto che questo è diverso, e io faccio molta fatica a svegliarli.
Lo sviluppo e la diffusione del digitale stanno cambiando il modo di pensare di giovani e meno giovani?
Credo di sì. In modo diverso, però, per giovani e anziani. I giovani scaricano semplicemente sullo smartphone, sull’iPad o sul portatile tutto ciò che devono ricordare. Tendono a fare lo stesso con i pensieri difficili. Se è troppo impegnativo, si rivolgono ai motori di ricerca e ora a ChatGPT; mi riferisco ai più giovani, all’età delle scuole superiori, non ai miei studenti di Design.
Le persone più anziane, a seconda della loro istruzione precedente e spesso del loro contesto socio-economico, hanno avuto il tempo, come me, di imparare e ricordare più cose, il che dà loro accesso immediato a contenuti interni per prendere decisioni, come ad esempio che cosa comprare o per chi votare. In confronto, i ragazzi di oggi, come sempre, probabilmente, vivono in “tempo reale”, ma ora è il tempo reale dei loro schermi, cui sono incollati.
In che direzione?
Anche in questo caso, potrebbe esserci una differenza tra giovani e anziani. I giovani non si preoccupano del futuro, almeno nei Paesi – in numero sempre minore – in cui questo futuro non è immediatamente minacciato. È solo quando raggiungono l’età della responsabilità che iniziano a preoccuparsi del loro futuro e a provare sgomento per le scarse opportunità. In confronto, gli anziani vivono più nel passato e dedicano tempo al presente solo quando fa male. È più probabile che abbiano contemporaneamente rimpianti e timori.
Un altro aspetto da menzionare, a questo proposito, è che la rapidità del cambiamento è di per sé un incentivo a essere reattivi piuttosto che proattivi. Le culture occidentali stanno finalmente iniziando a rendersi conto di quanto questo atteggiamento possa essere pericoloso in tempi sempre più brevi.
Impatto psicologico ed esistenziale: quali elementi vede come determinanti?
Il grande fattore determinante dell’impatto psicologico è che un nuovo tipo di inconscio è diventato molto più potente e immediato dell’inconscio personale di Freud e di quello collettivo di Jung. Io lo chiamo “inconscio digitale”, cioè tutto ciò che si conosce e che non si conosce. Potete vedere l’inconscio digitale all’opera nell’eccellente documentario The Digital Dilemma. Vi si vede un’analisi dettagliata e accurata di come i social media guidino surrettiziamente stati d’animo e scelte. È un fenomeno terrificante e ormai generalizzato. Dal punto di vista esistenziale, l’effetto principale è che i giovani sono ossessionati da come sono visti e apprezzati dai loro coetanei; il che è abbastanza normale tra i 10 e i 15 anni. Ora l’effetto si estende fino ai 18-20 anni e oltre. Si è arrivati al punto che i giovani passano più tempo a costruire la loro personalità a partire da questo riflesso esterno che da una motivazione interna più elaborata.
Il digitale cambia le persone più di quanto le aiuti?
Questo è un giudizio che non sono pronto a dare. Il vero problema è che, dal punto di vista tecno-culturale, stiamo tutti vivendo globalmente un doloroso periodo di transizione in cui la trasformazione digitale ha quasi eliminato gli standard e i riferimenti della precedente cultura alfabetizzata e non ha ancora completato la trasformazione e la piena installazione dell’infrastruttura e dell’ambiente digitale.
Ogni generazione sta sopportando il peso di questo cambiamento accelerato ma, con ogni probabilità, più giovani sono le persone in questo momento, maggiori sono le possibilità che sperimentino e accolgano il cambiamento in una forma completamente diversa. Più che cyborg, i giovani di oggi potrebbero, in quanto integrati cognitivamente – ed emotivamente – con le loro tecnologie sempre più potenti, essere componenti di sistemi autonomi simbiotici. Donna Haraway lo ha suggerito nel suo Manifesto dei Cyborg.
In particolare, quale impatto vede sulla formazione dell’identità dei giovani?
Ho iniziato a rispondere a questa domanda, in particolare per quanto riguarda le condizioni e le pratiche di formazione dell’identità. Vorrei aggiungere che, nonostante certe prevedibili tendenze tribali in età giovanile, c’è ancora una grande varietà di contesti culturali e socio-economici che definiscono lo sviluppo individuale. Quello che penso è che, anche se molte delle facoltà cognitive e relazionali dei giovani sono esternalizzate piuttosto che interiorizzate, il loro DNA rimane la chiave della differenziazione. Gli esseri umani del futuro potranno perdere la privacy, ma non le differenze individuali.
Cosa dovrebbero fare le scuole? E le famiglie?
Le scuole, oh le scuole! Sembrano così impotenti in generale, nonostante le brillanti eccezioni in Italia. Ho avuto il privilegio di conoscere un buon numero di rettori e di insegnanti davvero innovativi, esperti di pedagogia e ministri dell’Istruzione e relativi sottosegretari in gamba. Alcuni anni fa pensavo davvero che queste figure stessero imprimendo una tendenza e che il sistema educativo italiano potesse recuperare terreno nel suo complesso, ma ciò non sta accadendo. Il governo non ci arriva.
Al contrario, per esempio, i finlandesi mostrano al mondo come gestire le loro aule. Hanno dunque capito che l’istruzione deve essere la priorità assoluta di fronte ai cambiamenti rapidi, perciò non deve essere penalizzata: le scuole non vanno sottofinanziate e va sostenuta la formazione degli insegnanti alle nuove tecnologie. Infatti, non basta scaricare le tecnologie nella classe, ma bisogna formare gli insegnanti su come usarle e su come rimanere al passo con lo sviluppo che le riguarda. Osserviamo spesso che i ragazzi si annoiano a morte. Per quanto riguarda le famiglie, a parte il fatto che sono state duramente provate durante i due anni di chiusura a causa della pandemia, esse sono indifese quanto le scuole. Purtroppo, non c’è formazione sul comportamento delle famiglie, che devono imparare sul campo.
Quale criterio educativo fondamentale ritiene più importante da considerare?
Questa è la domanda chiave. La tecnologia sta portando l’educazione in una direzione opposta a quella in cui è andata finora. Invece di insegnare le risposte e chiedere agli alunni e agli studenti di rigurgitarle in sede di esame, gli insegnanti dovrebbero insegnare loro a fare domande. Già un decennio fa, quando si scoprì il valore dei Big Data, si sarebbe dovuto intuire che questa enorme sfera di informazioni aspettava solo le domande giuste.
Oggi, grazie a ChatGPT, si parla di “ingegneria della domanda”. Si tratta di un’abilità che dovrebbe diventare una priorità in qualsiasi contesto educativo. In genere, in tutto il mondo, gli studenti non vengono educati a pensare ma solo a ricordare, cosa perfettamente inutile quando si vive in un ambiente di informazione costante. Il risultato è quello che ottengo dai miei studenti internazionali di Design nel corso che tengo al Politecnico. Mi preoccupo di trovare articoli e video brevi e stimolanti, chiedendo loro di leggerli e vederli in modo da fornire domande per la lezione successiva. In pratica, devo pregarli di porre delle domande. Naturalmente, sono disposto a dubitare di me stesso, forse sono così lontano dalla loro realtà da non riuscire a stimolarli. Ma ho anche il sospetto che la maggior parte di loro non legga proprio alcunché.
A livello sociale, quali sono le conseguenze dell’uso delle tecnologie digitali e il ruolo delle comunità e dei corpi intermedi?
È una domanda talmente ampia che non so da dove cominciare. Quali tecnologie digitali? L’hardware, come lo smartphone, per esempio? È onnipresente sia dal punto di vista spaziale che temporale. Sta letteralmente affollando la vita sociale e minaccia di ridurla. Sembra che tutti siano in grado di intrattenere una conversazione, messaggiando o utilizzando qualche altra funzionalità del proprio telefono in modo del tutto naturale, anche se si tratta di incontri faccia a faccia. È talmente normalizzato che non si tratta più di buone o cattive maniere, ma solo di una parte della vita quotidiana.
O stiamo parlando di software? La grande domanda che si pone la mente, se non la bocca, di educatori, genitori e datori di lavoro è se le attuali e future generazioni di IA generativa miglioreranno o elimineranno le competenze. Perché preoccuparsi di imparare qualcosa, se una macchina farà sempre il lavoro meglio di voi? È proprio questo il punto di svolta che l’istruzione non dovrebbe perdere. Insegnanti e professori dovrebbero cogliere l’attimo per usare la nuova formidabile forza per accompagnarla, come un allenatore di aikido, non solo per sopportarla.
È possibile una governance della cultura digitale? Di chi è la responsabilità? Chi deve avere e interpretare una visione strategica? Lo Stato? Le stesse aziende digitali?
Sì, credo che la governance della cultura digitale non solo sia possibile, ma anche obbligatoria. Tuttavia, ancora una volta, come nell’aikido, senza contraddirla – è già troppo avanzata per fermarla –, ma accompagnandola con saggezza.
Lo Stato ha un ruolo da svolgere, un ruolo di supporto, non di dominio. La prima cosa da fare è tenersi in contatto con il grande pubblico e stabilire opportunità di consulenza reciproca, ad esempio creando e distribuendo centri di informazione e aiuto on e offline per stimolare la domanda e la condivisione con genitori, insegnanti, datori di lavoro e anche studenti. Per quanto riguarda le aziende digitali, che Dio ci aiuti, hanno abbondantemente dimostrato che non si occupano di aiutare le persone, ma badano ai profitti. In questo senso, non sono molto diverse dalle compagnie petrolifere, che si dichiarano a favore della conservazione e al tempo stesso aggravano il problema.
L’algoritmo diventa il decisore. È irrimediabile o si può reintrodurre una responsabilità umana consapevole?
In un numero crescente di casi, anche molto gravi e impegnativi come le diagnosi mediche, i verdetti legali o i giudizi finanziari, non è sempre necessaria una responsabilità umana consapevole, se non per le dovute verifiche. E questo va bene. La questione si complicherà quando la sofisticazione delle tecnologie diventerà tale da rendere superfluo anche il governo. Ho previsto questa possibilità per scherzo, come provocazione, qualche anno fa. All’epoca volevo essere divertente. Oggi sono meno sicuro che fosse solo una battuta.
ChatGPT: dai suoi studi quali indicazioni dà per usarlo bene?
Mi piace l’idea del “copilota”, ma proprio come in aereo, in cui deve esserci sempre anche un pilota! Detto questo, i miei studi sono ancora in corso. La prima guida che sto praticando ora, sia come insegnante che come utente, è quella di imparare il prompt-engineering. Anche se non ho intenzione di farne un lavoro, ho letto che negli Stati Uniti e in Canada ingegneri del prompt senza alcuna competenza di programmazione guadagnano fino a 350mila dollari all’anno, solo per il gusto di usare il cervello.
Ma che cosa significa usarlo bene?È come uno strumento musicale su cui bisogna esercitarsi. Le prime domande di solito danno risposte generiche, per lo più noiose. Ci sono molte strategie per renderle più eccitanti; ad esempio, porre la domanda come se ChatGPT fosse un personaggio famoso o un esperto di qualcosa. Io tendo a usare GPT-4, che è dotato di una serie impressionante di plugin che perfezionano la portata e la precisione delle risposte. GPT è come una città in cui si può entrare da molte porte diverse, ma una volta entrati si trova la propria strada.
La cultura umanistica: è finita o ha un futuro? Va salvata e trasmessa?
Assolutamente sì, è fondamentale. Sicuramente è finita come applicazione dominante dell’alfabetizzazione, ma rimarrà il modo migliore per sviluppare una forte personalità ed evitare di diventare un robot.
Leggere – e anche scrivere – è essenziale. Mi emoziona sempre vedere la piccola vignetta di una maestra che mostra un libro a un alunno perplesso e spiega: “Si chiama lettura; è il modo in cui le persone installano un nuovo software nel loro cervello”. Ciò che mi piace di questa immagine è il modo in cui mette in stretto contatto le due culture, quella digitale e quella letteraria, in modo collaborativo. Non dovrebbero mai essere separate, oppure estranee l’una all’altra.
Tutte le culture che hanno imparato a leggere, a Occidente oppure a Oriente, hanno sviluppato civiltà straordinarie e straordinariamente diverse e complesse. Tendo a paragonare i sistemi di scrittura ai sistemi operativi dei nostri computer, perché governano tutte le applicazioni. Allo stesso modo, così come l’ideografia ha definito la cultura cinese e altre culture orientali, tra cui quella giapponese e coreana, il nostro alfabeto, poiché traduce il linguaggio anziché le idee, ha creato nazionalismi costruiti intorno alla parlata locale, e individui che hanno sviluppato le loro diverse marche di pensiero grazie a ore e ore di lettura silenziosa.
Oggi il nuovo sistema operativo è la traduzione algoritmica del linguaggio. Non sta abbandonando il linguaggio, anzi lo sta assumendo, ma i suoi benefici saranno pari a quelli degli input. Gli LLM, i grandi modelli linguistici che forniscono contenuti per le risposte di GPT, costituiscono in qualche modo il nostro patrimonio umanistico. Non è il momento di perdere le nostre competenze linguistiche!
Come dovrebbe essere salvata e trasmessa la cultura umanistica?
Sostenendo la lettura in classe fin dall’inizio; leggendo letteratura, romanzi, opere teatrali e poesie; facendo in modo che gli studenti imparino, ricordino e recitino poesie, recitino opere teatrali e scrivano storie, con o senza l’aiuto di ChatGPT.
Occorre che gli studenti imparino almeno le capacità critiche sufficienti per valutare in modo equo e utile le proprie produzioni. Inoltre, gli studenti dovrebbero leggere anche su carta, non solo sugli schermi. Quando si legge su carta, il testo è al proprio servizio, si è padroni della propria lettura. Con gli schermi, non solo si viene tracciati e profilati, ma la lettura è costantemente interrotta da barre laterali psicologiche. Con ciò intendo le innumerevoli tentazioni di cambiare pagina, rispondere a un messaggio, cercare una nota a piè di pagina in Wikipedia: tutte distrazioni meravigliose, certo, ma che riducono la capacità di attenzione.
La cultura umanistica deve essere trasmessa e ampliata ovunque sia possibile, accompagnando l’ingegneria e la programmazione che diventeranno sempre più divertenti man mano che l’IA generativa si occuperà di questo lavoro terribile. Ma, se non avete sviluppato una forte cultura umanistica, presto non avrete nulla da programmare.
https://www.sussidiarieta.net/nuova-atlantide, 2024
______________________
Derrick De Kerckhove, nato in Belgio e naturalizzato canadese, è considerato l’erede intellettuale di Marshall McLuhan, di cui è stato assistente dal 1972 al 1980; è stato direttore del Programma McLuhan in Cultura e Tecnologia dell’Università di Toronto e docente alla Federico II di Napoli. Attualmente è Visiting professor al Politecnico di Milano. Emiliano Morrone è giornalista, attore e scrittore.